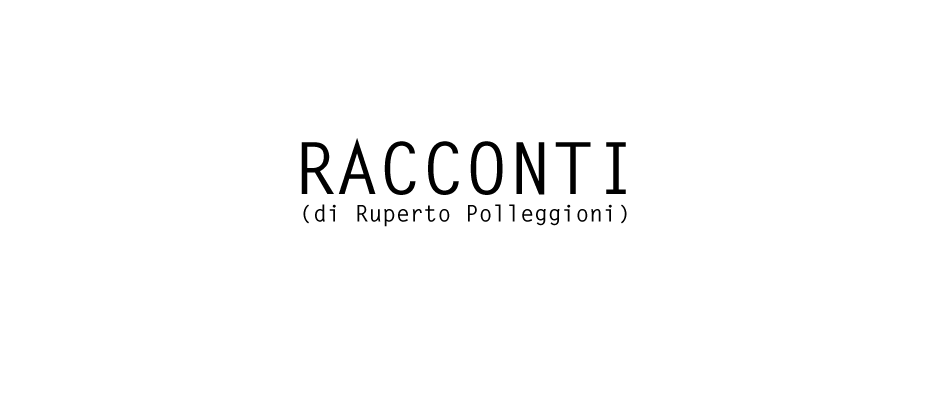“a M.D. per la luce che ha tenuto
accesa in me senza saperlo”
La verità – dissi a mio padre – è
che mi pesa la vita. Rispondere alle domande dei vecchi, a quelle
dei bambini. Cedere il posto sul treno, fare sorrisi controvoglia.
Badare agli altri e ricordarli, essere accondiscendente. Alzarmi al
mattino per lavorare, essere stanco. Non riuscire ad accettarmi,
escludermi consapevolmente. Odiarvi. E poi – aggiunsi – provare
vergogna per aver pensato tutto questo.
Lui fece solo un cenno con la testa
come a dire “ho capito, punto”. Sprofondato nel suo divano nero
era così stranamente simile a un pupazzo a molla che non mi sforzai
di replicare.
L'acido gastrico era già risalito per
l'esofago e il bruciore sarebbe arrivato di li a poco. “Prendi la
vita come capita” mi aveva detto un amico qualche giorno prima. Ora
per la rabbia ero in bagno che vomitavo il pranzo. La presi così
quella manifestazione di dolore
ricorrente che era formata da tanti silenzi e colpi incassati, come
se poi tutto sommato valesse la pena essere accondiscendente col
fato, se non altro per essere ricordato come un “brav'uomo”.
Forse a quello ambivo, essere ricordato. Uno sforzo notevole per
sopportare di essere buoni a tutti i costi mentre un male interiore
mi rendeva più brutto del necessario. Più mi sforzavo di non
deludere nessuno, più ero la delusione di tanti, più diventavo
cupo.
C'era qualcosa di
nero che era partito dal centro del mio corpo, poco più su dello
stomaco, che poco alla volta aveva infettato tutto il resto. Quel
nero pesava terribilmente e quando era giunto alla testa avevo avuto
l'impressione che una patina fosse scesa sugli occhi non
permettendomi più di vedere le cose realmente. Per ovviare a ogni
tipo di errore m'era sorta una strana immobilità che poi era
diventata paura di agire. “Non sbilanciarsi troppo” in qualche
modo era diventato un credo che non mi piaceva ma che m'accompagnava.
Mi feci terra bruciata di sentimenti temendo che “sentirli” mi
avrebbe costretto a una scelta, a una presa di posizione. Lentamente
mi staccai dalle sensazioni che di riflesso il mio corpo produceva e
tutto fu sostituito da un profondo e intenso respiro vuoto,
imprigionato tra la gola e il cuore.
Ero un microcosmo
di stelle spente.
In quel momento
così chiaramente freddo, l'unico pensiero andò a lei. Mi aveva
sopportato per tanto tempo. Forse ora mi avrebbe aperto di nuovo le
braccia in segno di pace. Io fuggivo spesso dalla mia vita, lei si
sostituiva senza saperlo al mare. Io ho sempre odiato il mare. Così
l'adoravo e la respingevo. Avrei voluto annegare nel suo grembo.
Diventare come un figlio riconoscente. Essere per sempre parte di lei
e, contemporaneamente, non essere, perché morendo non avrei più
sentito il respiro ma avrei respirato per l'ultima volta serenamente
sapendo di addormentarmi tra le sue vene.
Uscii di casa con
l'immagine di mio padre rassegnato, convinto che niente avrebbe reso
la mia esistenza migliore. Telefonai a lei, le dissi “vediamoci”.
Il “no” secco dall'altra parte della cornetta mi trapassò d'un
colpo come una scarica improvvisa.
Di lei avevo una
foto sempre nella tasca della giacca. Su quella foto avevamo riso
molto. Lei era piccola piccola e quella sua faccia non l'aveva
cambiata nemmeno da grande. Stessi occhi, stesso sorriso. Stessa luce
vitale di cui era piena.
A lungo la guardai
e riguardai. Piansi come solo i bambini sanno fare. Innocentemente.
Senza rabbia o tristezza. Ancora una volta le avrei detto “baciami,
ma non troppo forte”. Sarei finito nella sua bocca risucchiato dai
miei pensieri. Lei era stanca, forse come tutti quelli che mi stavano
vicino, del mio modo di non essere mai da una parte o dall'altre. Io
mi guardavo allo specchio e non ero sicuro se fossi io l'originale o
se, in qualche maniera, fossi costretto ad imitare le movenze di un
perfetto buffone.
Mi lasciai
trasportare dalla paura. Ero veramente solo in quel preciso istante.
A fronteggiare me stesso c'ero solo io.
Staccò il telefono
per evitare che la richiamassi.
Folgorante
fu il pensiero d'un palloncino che si agita al vento. Strattonato da
un lato e dall'altro non capisce più quale sia la spinta amica e
quale quella nemica. Vorrebbe solo volare. Arrivare al limite del suo
essere pieno d'aria. Esplodere. Un filo sottile, pensai, non può
impedire una così perfetta fine. Si sarebbe detto di quel palloncino
che era come tanti altri palloncini. Né più rosso o più tondo, né
più grande o più bello. Solo un palloncino. A chi importa mai di un
palloncino. L'unico che l'avrebbe rimpianto sarebbe stato il bimbo
che lo teneva legato al polso, che aveva instaurato un rapporto con
esso. Che, un po' per egoismo e un po' per piacere, s'era affezionato
a quello sventolare ondeggiante e continuo. Lui si che avrebbe pianto
di quella perdita. A lui non sarebbe importato se il palloncino si
fosse sentito più libero, più vivo. A lui sarebbe dispiaciuto di
non averlo avuto più vicino.
Fu un messaggio che
il caso mi suggerì.
Ci sono quei
momenti perfetti, in cui il cuore si riempie per pochi istanti di un
equilibrio imprendibile, delicati come i fiocchi di neve che cadono
lentamente e, a contatto con la mano che li accoglie, si sciolgono.
Mi incamminai quasi
spontaneamente verso il mare. Infondo se non potevo guardare i suoi
occhi avrei almeno respirato l'aria marina che mi ricordava il suo
odore.
Nel tragitto, che
mi parve infinito, ricordai con tristezza le miriadi di volte che del
silenzio avevo fatto un'arma. Ricordai le sue piccole mani che mi
cingevano i polsi come a dire “sei qui, ci sei veramente, sei
vivo!”. Se solo avessi potuto farle provare un attimo del mio
terrore al pensiero del mio respiro, forse avrebbe capito veramente
quanto necessarie fossero quelle fughe disperate e sole che
intraprendevo. Non c'era arrivata mai fino in fondo al nervo
scoperto. Non è che non c'avesse provato, è che non le riusciva di
vederlo il centro del mio dolore. Ci si avvicinava quanto più
poteva, ma niente. Restò notti intere a osservarmi, mi studiò.
Cercò di compiacermi in tanti modi. Tenne la luce accesa sapendo che
generavo buio. Non si arrese fino a quando non mi arresi io. Allora
quella luce flebile, che aveva alimentato, non la vide più nemmeno
lei. Fu una battaglia persa la sua, come una lunga passeggiata nel
deserto. Ero arido fin dentro il battito del mio cuore, e lei se ne
accorse. Con un gesto delicato scivolò via, senza scuotermi troppo
per paura che mi rompessi. Sacrificò buona parte della sua gioia per
una terra sterile. Io ero quella terra. Mi lasciò che fuori brillava
il sole. Un giorno splendente che mi portò a odiarmi. In tutta
quella chiarezza non potevo più nascondermi. Ero brutto. Con un
raggio che mi trafiggeva il ventre, partorii la creatura mostruosa
che ero diventato. Presi a ricercarla spesso, a rincorrerla per
vicolo stretti. Lei fuggiva nella realtà, nei miei sogni, nelle mie
fantasie. Sostituii tutto con tutto. Mi ritrovai a non cambiare
nulla, a ricominciare ogni volta daccapo.
Ricordando tutto
questo arrivai sulla spiaggia. L'acqua era limpida, l'aria secca. Il
mare mi apparì come una tavola con sopra una tovaglia di raso. Senza
posate, bicchieri o altro. Erano anni che non mi bagnavo in
quell'acqua salata. Mi tolsi le scarpe senza pensare troppo. Le
riposi ordinatamente verso il molo, riparate dalla sabbia, e dentro
ci infilai i calzini. Tirai su leggermente i pantaloni. Entrai.
Rivolto verso il
paese che s'ergeva sulla collina, diedi le spalle all'orizzonte
desolato.
Chiusi gli occhi.
Feci un inchino.
Alla fine di un
viaggio, senza nostalgia, bisogna guardarsi indietro e dire “è
stato un viaggio”, e dire “addio” come ci si è detti “ciao”
la prima volta.