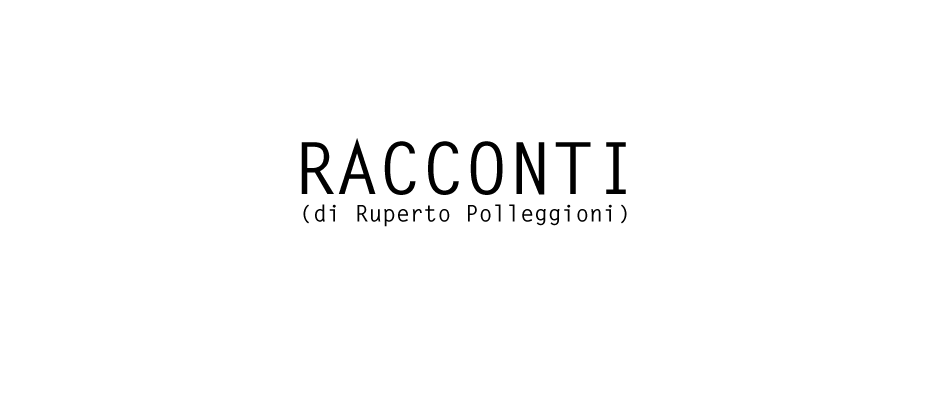Avrei potuto essere
armonico col mondo. Suonare tutt'uno con questa schifezza. Seguire il
direttore senza chiedermi alcunché sui suoi movimenti frenetici di
braccia autonome. Semplicemente interpretare i segnali principali per
seguitare a stonare in coro, così alla fine non si sarebbe potuto
imputare a nessuno l'errore e saremmo stati tutti ugualmente
colpevoli ma vivi.
Il prete mi da la sua
benedizione con il classico rito dell'estrema unzione e raccomanda a
un dio a me estraneo la mia anima, dice che a lui tornano tutte le
cose, lo dice con un volto sereno e una voce ferma, e tutto quello
che mi viene da pensare è se quando toccherà a lui sarà
altrettanto rilassato e convinto. Non lo guardo neppure in faccia,
visto che serve più a lui che a me tutta questa buffonata. Io non
l'ho chiamato, non l'ha chiamato nessuno per me, ma quello che mi sta
difronte aveva necessità di aggrapparsi a qualcosa e la guardia non
poteva certo elargire dolcezze, il prete è sembrato a tutti la
soluzione migliore. Ora però s'è fatto prendere la mano il tipo,
pretende che tutti nella sala d'attesa preghiamo assieme come
fratelli. Chi glielo spiega che tra meno di un'ora potrei essere in
grado di smontare tutta la sua gigantesca fede grazie ai miei
fratelli. Evidentemente nessuno ha il coraggio e a me importa troppo
poco per acconsentire o meno. Diciamo una delle più ipocrite
lamentele per il padre eterno e finalmente si congeda.
La guardia che ha in
custodia il mio dirimpettaio gli fa cenno di alzarsi. Comincia una
pantomima infinita. Quello sbraita. Si getta a terra. Implora la
vergine Maria. Bestemmia. Chiede perdono, si fa mansueto. Sputa in
faccia a una guardia. Tutto questo vede la fine un paio di metri più
in là quando la porta della cella si sbarra alle spalle del primo
candidato. Qualche altro secondo di show sonoro e poi è come se si
fosse rotta la radio di colpo, a nessuno dispiace.
Le guardie che mi fanno
compagnia si scambiano parole che non mi sforzo di decifrare. Uno dei
due però sentenzia divertito sull'esito della giornata – Oggi gran
frittura, eh? – L'altro annuisce e poi lancia un'occhiata a me che
lo fisso.
Io qui ci sono finito
volontariamente, come quelli che sperano che in una qualsiasi guerra
qualcuno li piazzi in prima linea, e le ragioni sono due, o vogliono
morire prima di aver sparato o ci credono talmente tanto in quello
che stanno facendo che la mania di protagonismo li insegue fino alla
morte. In entrambi i casi il finale è lo stesso, ed è quello che
spetta a me oggi, tra qualche istante, dopo che il mio
ex-dirimpettaio avrà concluso e il sipario sarà calato. Dopo
l'applauso compiaciuto della giuria.
E pensare che la mia
esistenza procedeva monotona e precisa come quella di tanti altri.
Mia madre era molto credente e oggi sarebbe stata contenta della
visita del prete, meno per la motivazione. Lei credeva, insieme a mio
padre, anche in qualcosa di concreto, che non si fondasse su
favolette, ma che fosse frutto di una buona borghesia
inculcatale da genitori poco presenti ma correttamente
piazzati al gradino giusto della piramide sociale. Io sono venuto su
come la maggior parte della popolazione odierna, in questa parte di
mondo dove il concetto di libertà è sinonimo di maggioranza e non
sempre hanno accezione positiva. “Una gran sensibilità” diceva
mio padre a mia madre quando tornava dall'incontro con gli
insegnanti. “Nostro figlio è un bambino sensibile!”. Non ho mai
capito se lo dicesse a mo' di sfottò o se cercasse di addolcire la
verità a mia madre sul fatto che me ne stessi sempre rintanato in un
angolo deriso dai più, e che fuggissi a ogni costo i rapporti
sociali.
Un giorno, sarà stato di
martedì o mercoledì, faccio il solito giro per andare a lavoro.
Compro il giornale per l'ufficio. Svolto a destra dalla strada
principale. Accelero il passo per evitare un ritardo seccante.
Un gruppo di ragazzini,
otto o dieci anni, si azzuffa. Un chiasso infernale che funge da
calamita per la mia testa. Mi giro di scatto senza alcuna intenzione
di intervenire. Poi vedo tutto. I ragazzini non si picchiano tra di
loro, ne picchiano uno solo. Lo sbeffeggiano. Lo strattonano. Gli
urlano contro. Con una di quelle bombolette piene di schiuma, simile
a quella da barba, lo riempiono fino a farlo diventare una specie di
pupazzo di neve. Non si accontentano, esagerano fino all'estremo.
Quello non si difende. Non può. I suoi aguzzini non si stancano, gli
danno addosso come si trattasse di una cruenta corrida. Cerca di
pulirsi gli occhi, rossi. Un misto tra lacrimazione forzata e pianto.
Una scena pietosa. Ancora più pietosa quando mi accorgo che il
ragazzino “non è normale”, come si usa dire impropriamente
quando non si è difronte a degli estranei o a un convegno, quando
l'appellativo “diversamente abile” pare a tutti troppo
impegnativo.
Rimango come una pietra.
Sono in ritardo. Poi mi gira la testa. Attraverso la strada e afferro
uno dei bulli da un braccio. Invito tutti a fermarsi, a smetterla. Ma
chi ti sente? Alzo la voce, li minaccio di chiamare le guardie. Si
staccano dal bambino-pentolaccia. Ho gli occhi sbarrati e la
sensazione è quella di stare su una zattera in mare aperto. Uno di
quelli che sembra essere il capo mi sferra un calcio, poi incita
tutti alla fuga ma non prima di aver riservato al coetaneo un sonoro
schiaffo sulla guancia.
Ci ritroviamo come due
imbecilli, io e il ragazzino. Mi avvicino ma quello mi manda al
diavolo. Lo fa con sincerità, non con rabbia. Aveste visto la
goffaggine dei movimenti mentre cercava di liberarsi da tutta quella
schiuma che iniziava a sciogliersi, ad appiccicarsi, a insudiciarlo
enfatizzando la sua inadeguatezza presunta col mondo.
Lo lascio lì, mentre
maledice tutti e urla “figli di puttana”, tirandosi una serie di
pugni, come se non ne avesse presi abbastanza. Mi allontano e quello
continua. Mi devo tappare le orecchie. Non basta, ci canticchio
qualcosa sopra. Sono in ritardo, non so nemmeno di quanto. Mi giro
ancora un attimo. Il bambino piange e si dispera, nessuno si ferma,
io mi aggrappo alla vetrata di un negozio. Scoppio a piangere
anch'io. Nessuno si ferma.
Qualche giorno dopo sono
in strada che cammino senza pensieri. L'episodio dei giorni passati
fa la sua comparsa quando meno me lo aspetto. Lo tengo a bada e il
nodo alla gola che si manifesta come reazione spontanea si scioglie
dopo poco. Infondo il mondo gira sempre dalla parte dei più forti,
mi dico, e ne ero convinto. Sbagliandomi. Il mondo gira sempre dalla
parte dei più numerosi, come mi avrebbe definitivamente insegnato la
società di li a poco.
Sono in strada e non
penso, cammino solamente. Una signora mi abborda rabbiosa. La vedo
partire dall'altra parte della strada che agita una borsa, una di
quelle esageratamente grandi che solo in certi posti come questo si
possono vedere. Attraversa incurante del traffico ma abbastanza
sicura di non volermi perdere di vista. Non la conosco, è la prima
cosa che penso, non dice a me! Come un fulmine mi finisce addosso.
Urla – Tu! Pezzo di merda – E la gente si gira attirata da questo
banditore pubblico – Come ti sei permesso! Mio figlio, l'amore mio.
Povero ragazzo! Io ti ammazzo! – Io sono lì che mi godo la scema.
Cerco di replicare – Signora io non credo sia la persona che
cerca... - Quella squilibrata si calma un attimo, almeno così sembra
– Lei l'altro giorno ha afferrato mio figlio per un braccio, l'ha
strattonato, minacciato di denunciarlo, e tutto questo perché
giocava rumorosamente con i suoi amichetti per strada! Come si è
permesso! Lei dovrebbe stare in carcere, o dentro qualche manicomio!
- Inutile quanto cerco di spiegarle, che in realtà il figlio non
stava giocando. Lei non sente. Ha le orecchie tappate.
Penso di aver proseguito
per una decina di minuti senza essere ascoltato, poi un dolore
tremendo si estende dalla testa fino all'addome. Come un pugile poco
attento finisco a terra. Sbatto la guancia sinistra sull'asfalto
maleodorante. Un nuovo dolore mi attraversa la colonna vertebrale.
Qualcuno mi sollecita le costole, forse più di uno. Non ho il tempo
di rendermi conto e credo che un infarto mi stia facendo un brutto
scherzo. Poi la voce di qualcuno che urla, qualcuno che cerca di
controbattere. Buio.
All'ospedale un mese dopo
mi sveglio da un lungo sonno. Il medico mi illumina gli occhi con una
piletta e mi dice – Guardi a destra. Guardi a sinistra – Lo seguo
senza la minima volontà di oppormi. Mi fa male tutto. Troppe ore al
computer? Il medico deva capire la mia perplessità perché comincia
a raccontarmi qualcosa che è avvenuto in questo mesetto di assenza.
Il rapido resoconto mi fa sospettare che si tratti del mio datore di
lavoro travestito per l'occasione. Poi viene al dunque – Sa chi
l'ha spedita qui? Una infuriata matta perché pare che lei abbia
picchiato suo figlio. L'ha fatta proprio incazzare quella – Ora
ricordo. Sul tavolino a fianco del letto un vaso di fiori della mia
ragazza. Un biglietto che mi avverte che non è in città, che mi
chiamerà. Che è triste ma che non poteva rimanere qui ora. Che mi
chiama appena mi sveglio perché è sicura che mi sveglierò.
Sorrido. L'amore non l'ho mai capito veramente. Lei dice che il cuore
le batte. Per me questo non è amore, è chimica. L'accontento la
maggior parte delle volte, alla fine non avrei motivo per odiarla. Ma
l'amore, proprio non so cosa sia. Qualcosa di convenzionale o no, a
me non l'hanno spiegato. A me va bene così.
La signora che mi ha
ridotto nello stato comatoso aveva architettato tutto, dicono gli
agenti. Posso sporgere denuncia perché aveva nella borsa un numero
consistente di mattoni. Voleva ammazzarmi e l'avrebbe fatto se non
l'avessero fermata dei passanti.
Mi guardo attorno per
cercare ispirazione sul da farsi. Ne ricavo solo una finestra aperta
dalla quale filtra luce azzurra. Deduco di lasciar perdere tutto e
dico agli agenti di non voler sporgere denuncia. I due se ne sbattono
altamente, e fanno bene. Con lo stipendio che si intascano ci coprono
a stento le spese fisse. Insistere con un infermo richiederebbe un
extra che non sarà pagato. Mi salutano e se ne vanno, passo svelto,
a mai più rivederci.
Telefono alla mia
ragazza. La segreteria dice che non è possibile disturbarla ora. Il
messaggio che lascio è solo un “qui tutto bene, rincoglionito,
solo e dolorante. Spero di uscire presto. Ti amo.” Non mi dilungo
mai al telefono. Odio quelli che ti costringono a chiamate
interminabili per renderti partecipe di tutte le disgrazie che sono
ingiustamente portati a sopportare. Io ho preso alla lettera il
“quello che non vuoi per te, non farlo agli altri” e questo mi
può bastare.
Esco dall'ospedale che
fuori minaccia di piovere. L'aria è fredda. La luce diffusa. Si
estende sulla gente una patina color ambra uniforme. Siamo tutti
perfettamente uguali. Un ragazzo canta una frase senza senso che si
rincorre. Ha la voce bassa, quasi rotta. Come se avesse un groppo in
gola. Penso che se gli dessi dell'acqua canterebbe meglio. La
chitarra la tiene bella stretta. Ha paura di perderla, penso. Le dita
sono stanchissime, tormentano un paio di note malinconiche. Non so
quali, di musica non c'ho mai capito. Dovrei ascoltare meglio. Dovrei
fermarmi, ma non ho voglia. Di tutte queste vite che mi passano in
fretta vicine, non mi frega niente.
Non sono mai stato un
tipo “sensibile” come dicevano a mio padre. Semplicemente non mi
è mai importato confondermi nella mischia. Non ho mai capito i
discorsi degli altri. Tutti quegli alti e bassi a cui ti costringono
per mantenere un rapporto civile con amici e conoscenti e parenti e
ogni sorta di essere vivente. Individui fallibile. Come me. La
differenza sta tutta nel fatto che io non ho mai predicato un bel
niente. Non ho mai cercato di convincere nessuno. Non volevo farlo da
bambino, non voglio farlo ora. Ho sempre lasciato credere a quelli
con troppa convinzione che fossero riusciti a persuadermi, l'ho fatto
senza sforzo, senza reagire. Avrebbe avuto senso dire la propria in
mezzo a una schiera di persone che la pensano diversamente ma alla
stessa maniera tra di loro? La risposta è no, e io non avevo
intenzione di cambiare le regole del gioco. Tutto sommato non ero che
il frutto di una notte d'amore di mia madre e di mio padre. Poi
borghesemente mascherato con un matrimonio e con un concetto di amore
che non era chiaro nemmeno a loro. Orfano, come tanti altri, di un
pensiero che non prevedeva l'aborto, che non contemplava la
convivenza, che accettava tutto purché non si venisse a sapere,
senza eccezioni. Una vita in pubblico ma con un copione che non aveva
nulla a che vedere con la realtà, dove anche questa era vista da
ognuno come meglio preferiva. Potevo io da solo prendere in mano la
società, dire no, urlare più forte di tutti questi essiccati
pensatori sotto vuoto? Non avrebbe avuto senso, lo penso ancora.
Prendete per esempio il
concetto di bellezza. Una cosa semplice, anche troppo. Ogni epoca
storica ha avuto i suoi canoni caratterizzanti di uomini e donne e
cani e modi e abiti che venivano presi come modelli per un bene
comune, che di comune non aveva niente, ancora meno di bene. Tutto
ciò che può essere diffuso, e lo è, non può diventare un modello
da raggiungere, altrimenti i più sarebbero convinti che sono già
perfetti. Che ogni sorta di miglioramento sarebbe superfluo. Forse il
primo teorico del concetto di “migliore” e del conseguente
“migliorare”, l'avrà fatto senza tenere conto delle conseguenze.
Ingenuo sul fatto che un grasso per costituzione non sarà mai
scheletrico, nemmeno se finisse in un campo di concentramento. Alla
stessa maniera un magro non riuscirebbe a diventare tanto grasso da
essere simbolo di fertilità. Una con un problema ormonale e numerosi
effetti sulla peluria potrebbe diventare liscia e glabra con
imponenti dosi di pillole dedicate o dolorose sedute dall'estetista.
Uomini con ossa geneticamente minute non saranno mai degli armadi
viventi nemmeno se vivessero in una palestra e non uscissero mai,
concentrati ad allenarsi tutto il tempo. I discorsi sul concetto di
bellezza che sento nei bar, quando raramente mi ci fermo, sono dei
più inutili e falsi. Uno dice “è bello oggettivamente”. Casomai
quello è pure laureato, fa il saputo con gli amici, ma non sa usare
le parole. Comunque le usa male, come la società gli ha insegnato.
Qualcosa mi disturba quando la schiera di scimmie parla
accavallandosi una sull'altra. Mi disturba perché i piccoli
mentecatti, intenti a formarsi, lo fanno con gli individui sbagliati.
Vengono su tutti con la fissa del cazzo che deve entrare in qualche
vagina prontamente calda e appetibile. Le bimbe quasi donne non si
sforzano nemmeno loro. Dopo tanti anni rinchiuse nelle faccende di
casa, l'unica via di uscita sta nella più totale degradazione
mentale. Quella fisica è solo una conseguenza. Mandrie di futuri
direttori di banca, di presidenti, di ogni sorta di impiego che
corrono verso vetrine e centri estetici e televisori e porcate a non
finire. Solo per sentirsi belli e belle. In nome di una normalità
che deve essere raggiunta, superata. Il podio non è per tutti ma
mio figlio ci arriverà. Questo era lo slogan di una pubblicità
che invitava i genitori a inscrivere i propri figli ad una delle più
prestigiose scuole private. Come a dire i poveri morti di fame che
combattono ogni giorno con problematiche diverse dall'estetica
possono e devono morire. O comunque che restino pure. Saranno
utilizzati come termine di paragone con l'élite.
La conseguenza peggiore
della stupidità umana che non ha il coraggio di dire “soggettivo”
ma che pretende che ci sia una certa oggettività in tutto e per
tutto, sta nel fatto che i rapporti umani sono sempre stati una farsa
tremenda. Il più debole è schiacciato, punto e basta. La risposta
non è “aiutiamo il più debole perché abbiamo più risorse di
lui”. No. La risposta è “sfruttiamolo, tanto più di questo non
potrà fare”. Quando non può essere sfruttato allora va deriso, va
sterminato. Se anche tutelato da qualcuno, va isolato. Che diventi la
diversità tra migliaia di diversi che però tentano di essere
uguali. Un “uguale” bello. Attraente, perché questo è tutto.
Come i bulli col ragazzino-pentolaccia. Sapevano che il pensiero
comune alla fine gli avrebbe dato ragione, perché il ribrezzo per un
gesto simile non esiste. Quei ragazzini sarebbero diventati belli
secondo canone. Brutti come tutti, marci da fare schifo, ma con corpi
scolpiti. Avrebbero tirato a fare gli stronzi per un sacco di tempo,
si sarebbero sposati e sarebbero diventati padri. I loro figli
avrebbero fatto lo stesso. Loro non sarebbero stati puniti per quel
gesto. Lo sapevano. Qualcuno disposto a investire su di loro ci
sarebbe stato. A dire il vero la maggior parte avrebbe investito solo
su soggetti come quelli. Il ragazzino tutta schiuma, con gli occhi
rossi che non sa comunicare, vorrebbe solo sentirsi parte di questo
stramaledetto sistema defecante. Ignaro di quello che significa
veramente. Per lui non c'è posto. Non c'è amore oltre quello dei
genitori o di qualche volontario in cerca di crediti e di scalate
sociali. Non c'è donna che lo reputi bello secondo canone. Il canone
non è quello, è l'adone di turno, e il ragazzino non sarà mai
adone, nemmeno se pregasse tutti gli idei che ci sono sulla terra.
Nemmeno se si sottoponesse a migliaia di chirurgie estetiche. Il
sistema l'ha bollato. Non è normale, casomai diversamente abile, ma
non abile come “piace a noi”.
Tutto questo lo penso che
me ne vado dritto a casa.
Io dico sia stato un
caso, ma mi piace pensare che qualcosa doveva portarmi a tutto
questo. Io che alla fine non mi ero mai soffermato a riflettere sulle
conseguenze delle azioni. Di come un semplice passo sbagliato possa
farti sciogliere un laccio di una scarpa e che il tempo di
risistemarlo ti faccia perdere il bus, e che cominci a piovere, e che
una pensilina in un vicolo diventi il rifugio per molti, e che lì,
tra tutta la gente che si ha la maniera di non incontrare, si
incontri proprio quella giusta.
Ci penso perché il
bulletto con la madre quasi assassina mi è difronte. Di spalle.
Sotto il mio sguardo. La pioggia cessa e ci diradiamo in fretta. Ma
perché mai lo sto seguendo non lo so dire. Voglio vedere dove abita.
Forse. Lo seguo a distanza. Per un sacco di tempo. E se quello un
giorno diventasse un criminale? La domanda che non mi aspettavo me la
faccio da solo. Mi sconvolge la risposta che mi do. Diventerà
sicuramente un criminale. É categorico, senza ombra di dubbio. La
mia educazione borghese che ho sempre cercato di schivare ora è più
viva che mai. Non ho dubbi, possibile? Il cervello è sicuro come se
si trattasse di qualcosa di scientifico, e siccome le teorie sono
vere fino a prova contraria, allora cerco la prova. Non arriva. Non
c'è. Accelero il passo. Corro. Il ragazzino non si accorge di
niente. Lo afferro dal braccio. Gli tappo la bocca. È una sensazione
strana. Fa resistenza. Ma io sono più forte. Ho più volontà.
Stavolta non è più al sicuro nella sua spavalderia. La società mi
insegna qualcosa di nuovo. La maggioranza vince e un uomo solo non
può nulla. Qui siamo uno contro uno ma il confronto è impari e
quindi mi considero in due contro il ragazzino. Come un vigliacco,
penso. Ma non posso certo dividermi a metà e ricompormi solo a cose
fatte. Penso che con me ci sia il ragazzo-pentolaccia. Questa cosa mi
da forza. Premo sul collo fragile dell'insicuro sbeffeggiatore, e lo
strangolo. Cade a terra che già non respira più.
Se vi devo dire di aver
provato vergogna, di essermi sottratto alle guardie, che poco dopo mi
hanno fermato, con insolita meraviglia, negando tutto, mentirei. Non
ho provato nulla.
Infondo la società
uccide sempre. Il concetto di normalità fa sentire i diversi nel
torto, come se quella diversità dipendesse da loro. Molti non
reggono la solitudine, il disprezzo che gli viene rivolto,
l'insicurezza nei gesti, la malinconia di tutto quello che gli viene
negato, e si ammazzano. Morti pulite. Senza assassini. Ma solo perché
non si vuole ammettere che gli assassini sono ovunque. Da quello che
scrive ingenuamente “ricchioni” sopra al portone di un palazzo
del centro, a quello che indossa un credo razziale, al datore di
lavoro che chiede in cambio rapporti sessuali per un'assunzione, alla
massa di insensibili sfruttatori di più deboli.
Io ho semplicemente fatto
quello ho fatto.
Piove fuori, così dicono
le guardie. A me la pioggia è sempre piaciuta. Un odore particolare,
soprattutto d'estate, dopo un po' che c'è il sole e l'asfalto è
abbastanza caldo da cuocerti se ci si fermasse più di cinque minuti
per riposare. La pioggia inevitabilmente porta con se un numero
variabile di nuvole che tolgono luce e fanno sembrare quasi notte
ogni ora del giorno. Una condizione che spinge molti ad essere sempre
assonnati, in cerca di qualche appiglio che funga da letto.
L'applauso
della giuria risuona prepotentemente in questo carcere abitato solo
da pagliacci in fila per l'esibizione, sorvegliati a vista, con una
scadenza decisa. Pronti ad alzarsi a comando, a prendersi ogni tipo
di colpa per ripulire l'interno di esseri umani più furbi o
solamente scemi, che non si espongono per volontà o perché non ne
sono capaci.
Avrei
potuto continuare a stonare in coro, seguire il direttore, ma forse
ho preso la nota giusta, forse ho stonato troppo forte. In ogni caso
questo è inaccettabile.